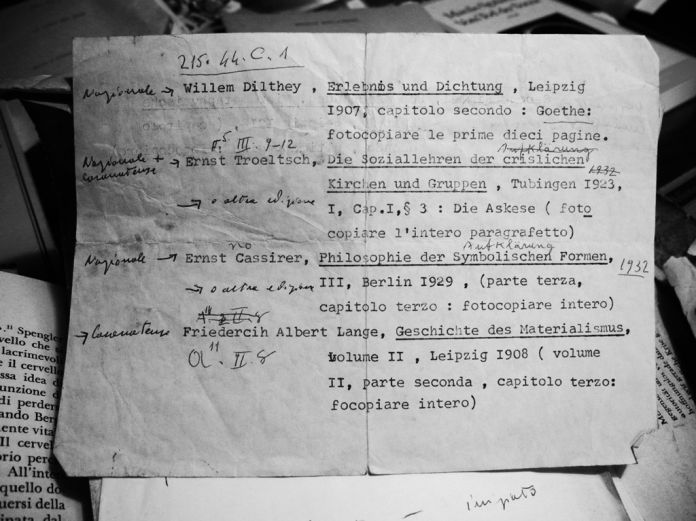In ricordo di Manlio Sgalambro (Marcello Faletra)
È difficile parlare in Italia di un filosofo come Sgalambro, scomparso tre anni fa. Nelle aule universitarie lo si evita volentieri. D’altra parte, il suo pensiero non era deliberatamente conforme all’insegnamento cattedratico. Il ricordo di Marcello Faletra.
Spogliato di qualsiasi illusione, Manlio Sgalambro (Lentini, 1924 – Catania, 2014) ha preferito frequentare i sotterranei del pensiero, l’underground umorale che lo segnava. La sua scrittura ha il tono di Kierkegaard ma senza Dio, sfiora quella di Nietzsche, ma senza il superuomo; ma, più ancora, è vicina a quella di Schopenhauer di cui ne eleva a potenza il principio di rappresentazione: “Il mondo è la rappresentazione di una rappresentazione”. Mentre il vero grande filosofo della ragion pratica per Sgalambro non è Kant, ma l’eroe di Cervantes – Don Chisciotte – colui che lotta contro il nulla dei mulini a vento. Ha praticato l’estremismo del verbo fino al paradosso. Uno stile tagliente come il giuramento o il telegramma, ma pure come l’epitaffio, senza negoziazioni. Dritto al cuore delle cose. A volte scriveva per immagini; e qui le virgole, i punti, le citazioni in lingua originale dal tedesco al latino fanno piroette, circuiscono pensieri e immagini, li ritmano, li tagliano, li sospendono improvvisamente. Una punteggiatura che trasforma il pensiero in una danza.
SPINOZA FONTE DI ISPIRAZIONE
Suo insostituibile compagno della notte fu Spinoza, che tenne sul comodino per oltre mezzo secolo: “Egli ha saputo fare in modo da non essere autore dell’Etica. Spinoza esordì con la propria fine. In lui non c’è più il soggetto, tanto assoluto quanto fragile, ma solo l’opera”.
Sgalambro proviene da una terra dove l’effusione e la contemplazione, la sguaiataggine e il gesto aristocratico, la confidenza e il segreto, l’irruenza della comunicazione, a volte impudica, e la reticenza sono un modo di esistere. Una terra dove si sa tutto di tutti, e quando non si sa nulla, si inventa pure la vita degli altri. Una terra dove la vita in comune sottostà al giogo del confessionale pubblico, e dove il segreto è inimmaginabile, perché la loquacità, spesso, confina con il delirio. Il suo misantropismo germoglia in questo teatro della vita.
IL ROCK COME ETICA ED ESTETICA
Non l’ho mai sentito diffamare amici o nemici. Una forma di superiorità che stemperava nella battuta ironica. Ogni suo pensiero ha stretto un’alleanza mortale con l’irreversibile, con l’effimero della vita. I suoi frammenti poetici risuonano dei segni distintivi di tonalità affettive: la penetrazione degli odori, la danza dei suoni, le sconfitte dei sogni a occhi aperti. Gli autori amati di ieri e di oggi. Il suo verso non era al servizio dell’essere, ma dell’ente. Si alleava con l’irreversibile, e a volte assorbiva la malinconia che esala dalle ceneri dell’erba bruciata o dalle più umili sonorità di una canzone che mineralizza come una danza macabra tre minuti di vita. D’altra parte per Sgalambro la canzone, e più di essa il rock, parla di etica e di estetica più di qualsiasi corso universitario dedicato. Un frammento della sua teoria della canzone dice: “La canzone insegna relazioni umane. In ogni canzone, non esclusa la più umile, l’altro è presente. Hendrix il pazzo insegnava morale dal palcoscenico”.

SGALAMBRO DISTRUTTORE DI CERTEZZE
Debellatore delle legittimazioni che puntellano la buona coscienza metafisica, ossessionato dall’irresolutezza etica del pensiero occidentale, Sgalambro ha perseguito uno scopo: la rovina dell’inviolabile, così come Wittgenstein volle quella del linguaggio. L’eccesso di lucidità del suo pensiero ha trasformato il pessimismo in metodo: rovesciare il senso comune, beffarsi del conformismo del pensiero che sale dalle cattedre universitarie come un catechismo. In questo singolare metodo il pessimismo diventa un acceleratore di energie e di immagini. È, cioè, l’esercizio della consumazione, l’arte di fare buon uso della sparizione, per essere all’altezza della propria morte. Era un distruttore di certezze che accresceva l’esistenza, l’arricchiva frammentandola. Ma, nell’uno e nell’altro, la stessa distanza dagli esseri e dalle cose, la stessa inflessibilità, la stessa tentazione del silenzio, del ripudio finale del verbo, la stessa volontà di impattare contro limiti mai esplorati. Se fosse nato più a sud sarebbe stato attratto dal deserto. Il suo volto era già un’opposizione, impenetrabile, distante da tutto. Ma il suo sorriso tradiva un pentimento inconfessato di semplicità. Aveva la forza di sorprendere, ma anche il potere di sparire. Pervaso da una naturale assenza di ostentazione, dialogava con tutti. Un uomo della città e della folla, ma anche un misantropo ostinato, dell’insegnamento segreto per alcuni, della gloria anonima per altri.
Dotato di una grande violenza razionale, ha ridotto il pensiero a un ammasso di frammenti; la ricerca delle cose ultime lo fece approdare fino alla ineludibile certezza de La Morte del sole (il libro che lo rivelò al pubblico). In questo libro, tradotto in più lingue, vi è una geografia della disgregazione, un prontuario della dissoluzione di tutte le cose, un armamentario del pensiero pronto all’offensiva della catastrofe universale – la morte dell’astro – da cui non ci libereremo mai. Attribuiva all’universo un atteggiamento umano, ma solo per ricordare agli uomini che spariranno. In questo libro, come in tutti quelli che seguiranno, si afferma il gusto del suo autore, che, al modo di un flâneur, odora la vita, vi passa in mezzo e poi segretamente scompare nel nulla.
– Marcello Faletra