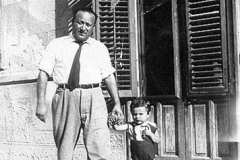Infanzia
La famiglia, la mafia, le scelte
La famiglia Impastato
Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio 1948 da Felicia Bartolotta e da Luigi Impastato. Felicia proveniva da una famiglia piccolo borghese: il padre lavorava al Municipio, ma era anche proprietario di terre e case: non aveva rapporti con la mafia, anche se un suo fratello, Rosolino, emigrato in America, era diventato un gangster, con il curioso soprannome di Semibruno. Costui aveva sposato Anna Rubino, figlia di parenti mafiosi di Terrasini: in seguito al mancato saldo di una partita di whisky, il padre di Anna aveva ferito, a colpi di pistola, Pietro, fratello di Rosolino, e quest’ultimo, per vendetta, aveva ucciso il suocero e i due cognati:
«Ora, sua moglie capiva che suo marito aveva ragione. Ché suo padre era soverchioso, era abusivu (prepotente). Gli amici lo nascosero. Agli amici lei diceva: «Perché non devo fare pace con mio marito? I miei avevano torto». Insomma, poi fecero pace, marito e moglie, perché si volevano bene pazzamente, perché lei pure veniva da una famiglia mafiosa. Perciò, «tu mi tincisti e io ti mascariai (tu mi hai tinto e io ti ho macchiato)».
Nello stesso libro, da cui abbiamo tratto l’episodio, e che costituisce una drammatica testimonianza della sua esistenza, la signora Felicia ricorda:
«Ero fidanzata con un altro. Ma io non lo volevo. Mi sarebbe piaciuto uno di Castelvetrano che mi voleva, era uno buono. Ma mio padre non ha voluto, perché non voleva che andassi fuori dal paese. Prima si stava all’ubbidienza. Io stetti all’ubbidienza e mi feci fidanzata con uno onesto, però, gente onesta e lavoratrice. Io però non lo volevo. Arrivai ad esporre il corredo, ma quando dovevo andare a sposarmi, dissi: «Non lo voglio». Andai a trovare mio fratello di notte. Gli dissi: «Sono venuta qua perché non mi voglio sposare, non lo voglio». Allora lui andò da mio padre e gli disse che io non mi volevo sposare. Mio padre insisteva, ma io gli dissi: «Non lo voglio». E siccome allora si usava fare le “fuitine”, gli dissi: «E non mi devono toccare neanche un capello, perché mando in galera per primo voi». Poi mi feci fidanzata con questo, mi piaceva, lo devo dire. Appena mi sono sposata ci fu l’inferno». (ib. p. 23)
Luigi Impastato proveniva invece da una famiglia con forti connotazioni mafiose: basti ricordare, tra i suoi parenti, quel don Tomasi Impastato, capomafia di Cinisi nell’immediato dopoguerra.
Durante il fascismo era stato confinato, come mafioso, ad Ustica, per tre anni, poi ridotti a due. Il padre era un allevatore: pare che con la famiglia Badalamenti non corresse buon sangue:
«Non so cosa fecero i Badalamenti, ricorda la signora Felicia, e incolparono mio suocero, e un cugino di mio suocero e li misero in carcere. Si fecero due anni, poi uscirono. Allora mio suocero chiamò tutti i suoi figli, compreso mio marito, Simone, Jacuzzu, Luigi, Peppino, Nardo e tre femmine, otto figli, e disse loro: «Io vi lascio per testamento che con i Badalamenti non ci dovete avere niente da fare, per nessun motivo, perché vi scomunico… “Battagghi” non li dovete mettere neanche alle vacche» (ib. p. 18).
Tuttavia pare che non tutti i figli abbiano tenuto in gran conto l’anatema del padre, perché hanno finito con il far parte più o meno organica della cosca dei Badalamenti: forse, paradossalmente, l’unico a rispettare quel testamento, ma per altri motivi ed altre scelte, fu il nipote Peppino. Per Luigi il matrimonio, nel 1947, rappresentò una buona occasione: costretto a vivere da “intrallazzista”, trasportando formaggi, e ad arrangiarsi con altre forme di commercio, sposava una giovane di buona famiglia che gli portava in dote diverse proprietà; ma ciò che fece innalzare di colpo le sue quotazioni e quelle della famiglia fu il matrimonio di una sua sorella con il capomafia riconosciuto di Cinisi, Cesare Manzella. Intanto nasceva Peppino e, qualche anno dopo, un altro figlio, morto a causa di un’encefalite: per evitare contagi, Peppino fu condotto presso la nonna materna e finì con lo stabilirsi lì. Nei suoi pochi contatti, il padre lo portava in giro tra i boss del paese, sperando di farlo crescere in base ai suoi principi. Il mancato rapporto con la figura paterna era sostituito da quello con lo zio Matteo, che provvedeva a vestirlo, a nutrirlo e a farlo studiare, ma tale distanza e tale mancanza d’amore, con il passare degli anni doveva diventare abissale. Peppino frequentò la scuola media a Cinisi e il Liceo classico a Partinico: i compagni lo ricordano come un ragazzo intelligente e vivace, con un grande bisogno di amicizia e di socializzazione: il contatto con alcuni di loro, figli di militanti della sezione del PCI di Cinisi, servì a destare i primi interessi verso la politica.
Della sua adolescenza, un ricordo di Stefano Venuti:
«Ai miei comizi ricordo sempre presente un ragazzino che, mentre tutti quelli della sua età giocavano e correvano, se ne stava seduto sul marciapiede ad ascoltare per tutto il tempo. La prima impressione che ebbi quando lo conobbi, fu quella di un ragazzo dotato di entusiasmo e di un desiderio enorme di giustizia, di pulizia, di onestà».
In una breve nota autobiografica, Peppino scrive:
«Arrivai alla politica nel lontano novembre del ’65, su basi puramente emozionali: a partire cioè da una mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile. Mio padre, capo del piccolo clan e membro di un clan più vasto, con connotati ideologici tipici di una società tardo-contadina e preindustriale, aveva concentrato tutti i suoi sforzi, sin dalla mia nascita, nel tentativo di impormi le sue scelte e il suo codice comportamentale. È riuscito soltanto a tagliarmi ogni canale di comunicazione affettiva e a compromettere definitivamente ogni possibilità di espansione lineare della mia soggettività. Approdai al PSIUP con la rabbia e la disperazione di chi, al tempo stesso, vuole rompere tutto e cerca protezione. Creammo un forte nucleo giovanile, fondammo un giornale e un movimento d’opinione, finimmo in tribunale e su tutti i giornali. Lasciai il PSIUP due anni dopo, quando d’autorità fu sciolta la Federazione Giovanile. Erano i tempi della Rivoluzione culturale e del “Che”».
I due anni di militanza nel Psiup lasciano in Peppino tracce indelebili , soprattutto nell’attenzione ai problemi del mondo operaio e contadino , nella condanna del militarismo americano, dell’autoritarismo sovietico, nell’attenzione ai temi della resistenza e dell’antifascismo. Diventa responsabile della sezione giovanile di Cinisi, entra nel direttivo provinciale, partecipa come delegato della provincia di Palermo al congresso nazionale di Livorno agli inizi del ‘68. Significativa una testimonianza di Moffo Schimmenti:
“Siamo arrivati con mezzi di fortuna a Grosseto. Non avevamo soldi e dovevamo arrangiarci. Per arrivare a San Vincenzo abbiamo avuto un passaggio da un contadino con il carretto. Al congresso abbiamo conosciuto Rostagno, Viale, Bobbio, di qualche anno più grandi di noi. Peppino e io siamo stati in due commissioni diverse. Ci vedevamo solo durante i pasti e le assisi generali. Peppino aveva il posto per dormire nella mia stanza, ma aveva incontrato una compagna napoletana ed era sparito. Per due notti non si è visto e quando dovevamo ripartire sono andato a prenderlo nella stanza della compagna. Al congresso abbiamo presentato, assieme agli altri compagni siciliani, una mozione di solidarietà alle popolazioni del Belice. Peppino poi è entrato nella direzione nazionale, ma subito dopo la federazione giovanile nazionale fu sciolta, per le idee troppo avanzate rispetto alla direzione del partito” (vedi “Lunga è la notte” pag. 189-190). Moffo fa richiamo anche alla grande manifestazione studentesca del ’68, a Palermo, che raccolse 10.000 partecipanti dietro un preciso slogan: “Sicilia rossa, mafiosi nella fossa”. Tanto per ricordare che la lotta alla mafia ha radici molto più lontane di quanto oggi si voglia far credere.
Intanto la vita, a casa di “don” Luigi scorreva nella sua drammatica, allucinante, quotidiana cadenza: talora i carabinieri venivano a cercarlo ed egli si nascondeva in uno stanzino sotterraneo, coperto e occultato da una cassapanca2; talora, esasperata, Felicia scappava a nascondersi in casa della madre, come quando scoprì che il marito la tradiva con una vicina di casa:
«Lo seppe il marito della donna, i parenti andarono a bussare e lui uscì in mutande. Io allora scappai, presi mio figlio e me ne andai dai miei parenti. Dissi: «Io non lo voglio vedere più». Allora venne Cesare Manzella, pieno di gentilezze, e mi disse: «Sai, che vuoi fare?» E andava, veniva, andò da mia madre… e poi dovette dare soldi, a quella donna, per accordarsi. parlò pure con mio fratello: «Tu sei responsabile di tua sorella» «E perché?». «Perché li devi fare mettere d’accordo». «Deve essere lei che deve accordarsi, che devo dire io?». «No, tu sei responsabile». Mio fratello disse: «Guarda, Felicia, vattene perché c’è poco da fare». Però il sangue restò sporco, lo stomaco malato. Cioè io lo rispettavo, lo trattavo bene, facevo secondo educazione, i figli li tenevo vicini al loro padre, insomma non detti scandalo. Così la gioventù mi passava sempre… Poi crebbe Giuseppe ed era l’inferno a casa mia».
Un inferno scandito dagli atteggiamenti arroganti di Luigi, che su tutto pretendeva di decidere, dai suoi improvvisi scatti d’ira che lo spingevano a tirare la tovaglia della tavola apparecchiata e a rompere tutto, un inferno scandito dalla paura, come quando vennero uccisi in piazza Mazzola e Bernardinu (Antonino Palazzolo), e Manzella, mandante del delitto, in via precauzionale, fece trasferire la moglie e il piccolo Giovanni a Contessa Entellina, dove viveva e lavorava il cognato Giuseppe Impastato, detto “Sputafuoco”, da lui sistemato come gabellotto nei feudi dell’on. democristiano Pecoraro. Ma l’inferno vero cominciò quando Luigi fu messo al corrente delle scelte politiche del figlio: Felicia diventò la valvola di scarico di una condizione nevrotica esplosa nella scoperta dell’impotenza d’intervento del padre presso il figlio e accentuata dall’accusa, da parte degli altri membri del clan, di non avere saputo educare il figlio secondo le giuste regole, peggio, di averne fatto un nemico:
«un martirio… quello che ho passato… la dittatura… sul niente attaccava brighe… disperazione e paura… quando lo sentivo arrivare mi pisciavo addosso… mai una parola dolce, mai uno svago, mai una festa, mai una lira… teneva tutto in mano…, mi faceva uscire solo per andare a trovare Tanino Badalamenti e parlare con sua moglie… mai un regalo, quello che ho passato, solo io lo so, e anche Peppino se lo immaginava, mi diceva: «Io vegnu cca sulu pi tia»
È ciò che ho sentito da questa donna, tra un singhiozzo e l’altro.
(Dal libro di Salvo Vitale: “Peppino Impastato, una vita contro la mafia” ed. Rubbettino, nuova edizione del 2002)